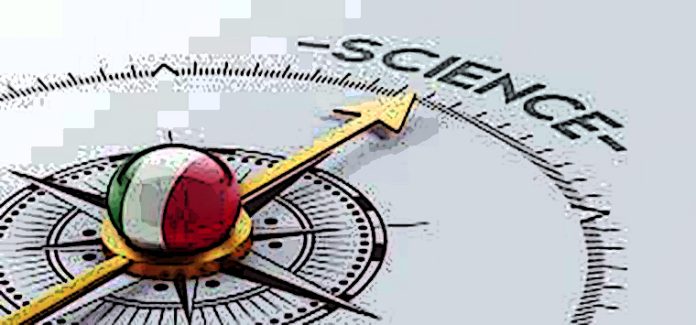Rom a, 17 ottobre – Robert Nisticò, presidente dell’Aifa (nella foto), intervenendo nel corso degli Stati generali della ricerca medico-scientifica promossi dal Senato della Repubblica e dai ministeri dell’Università e Ricerca e della Salute, aperti il 14 ottobre a Palazzo madama dal Capo dello Stato Sergio Mattarella e chiusi ieri, ha voluto ricordare quello che – in Italia – è il vero problema: quattro studi clinici su cinque sono finanziati dalle aziende.
a, 17 ottobre – Robert Nisticò, presidente dell’Aifa (nella foto), intervenendo nel corso degli Stati generali della ricerca medico-scientifica promossi dal Senato della Repubblica e dai ministeri dell’Università e Ricerca e della Salute, aperti il 14 ottobre a Palazzo madama dal Capo dello Stato Sergio Mattarella e chiusi ieri, ha voluto ricordare quello che – in Italia – è il vero problema: quattro studi clinici su cinque sono finanziati dalle aziende.
Ovviamente, gli sforzi delle aziende sono i benvenuti e sono necessari, “altrimenti” ha detto il presidente di Aifa “non avremmo tutti questi farmaci innovativi”. Ma non va bene, non può andare bene questo strapotere della ricerca privata, perché vuol dire che per contro la ricerca pubblica è in grave sofferenza. E lo è da tempo, e per ragioni tutte note, su tutte il finanziamento pubblico insufficiente e in costante calo e la correlata e conseguente fuga dei nostri cervelli in altri Paesi, nonostante le alate dichiarazioni che da anni assicurano il massimo impegno per invertire queste tendenze, senza però mai tradursi in politiche concrete.
“Questo quadro non è ideale, poiché la ricerca dovrebbe essere un equilibrio tra finanziamento pubblico, privato e filantropico, con il settore pubblico che garantisce indipendenza e lungimiranza” ha affermato al riguardo Nisticò. “Però bisogna salvaguardare la ricerca indipendente. Come Aifa, da quando sono presidente, ho voluto spingere su questo fronte: è aperto un bando sulla Medicina di precisione e l’anti-microbicoresistenza. E insieme alla ricerca indipendente va anche salvaguardata l’informazione indipendente”.
Un messaggio importante, quello lanciato da Nisticò, soprattutto perché proveniente da un’importante autorithy pubblica. Ma che servirà a ben poco se la politica non invertirà la rotta seguita da troppi anni, fatta da investimenti pubblici molto modesti e tendenzialmente in calo, oltre che concentrati in prevalenza sulle spese ordinarie e per il personale (con il risultato che per la ricerca vera e propria rimane poco o nulla).
I numeri sono molto più eloquenti di qualsiasi parola: la spesa dell’Unione europea per ricerca e sviluppo, nel 2022, ha raggiunto i 352 miliardi di euro, quasi il doppio rispetto al 2012. I Paesi che investono più risorse, con percentuali superiori al 3% sul Pil (soglia che rappresenta l’obiettivo fissato a Bruxelles per i Paesi Ue), sono Belgio (3,44%), Svezia (3,40), Austria (3,20) e Germania (3,13). L’Italia è lontanissima, diciottesima con l’1,33%, in un calo rispetto all’1,41% del 2021, a dimostrare che il nostro Paese, in materia di investimenti in ricerca, va come i gamberi, nonostante le reboanti dichiarazioni di intenti su un “cambio di marcia” (risuonate anche durante gli Stati generali dei giorni scorsi in Senato) che però non si vede mai.
Con divari di questa portata e una spesa pro-capite per la ricerca molto inferiore a quella di altri Paesi europei, è facile comprendere che l’Italia non solo non potrà andare molto lontano, ma rischia proprio di fermarsi del tutto. E la fuga dei cervelli, prima e principale conseguenza della carenza di fondi pubblici, che costringe i ricercatori italiani di cercare di lavorare all’estero, è al riguardo qualcosa di più che un semplice segnale negativo.
Ma c’è dell’altro: la combinazione tra una ricerca che dipende in via (quasi) esclusiva dai finanziamenti privati – che sono comprensibilmente indirizzati verso aree dove si ritengono più immediati ritorno degli investimenti e profitti – e l’inadeguatezza dei fondi pubblici limita inevitabilmente la capacità di fare ricerca pura, cioè non finalizzata al profitto, ma comunque strategica ed essenziale per il Paese.
Le implicazioni sono pesanti: alla fuga dei cervelli nostrani, si aggiunge la minore capacità attrattiva del nostro Paese per i ricercatori di altri Paesi, che – nonostante il loro numero sia in crescita a livello globale – in Italia faticano a trovare finanziamenti adeguati per la ricerca fondamentale e di lungo periodo.
L’insufficienza e precarietà dei fondi pubblici, inoltre, genera instabilità nel sistema di ricerca, rendendo difficile la pianificazione a lungo termine e la creazione di progetti ambiziosi. I ritardi, insomma, innescano un circolo vizioso che genera altri ritardi e arretramenti, e tutto questo mentre il treno della competitività passa veloce. Un treno che stiamo inesorabilmente per perdere, con tutte le conseguenze che ne verranno non solo nel presente e nel domani immediato, ma nel futuro a lungo termine.
Secondo il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervenuto all’inaugurazione degli Stati generali della ricerca il 14 ottobre scorso, in questa legislatura l’Italia ha dato un “chiari segnale di attenzione” al tema della ricerca, ad esempio sul tema del rientro in Patria di molti dei ricercatori, con iniziative finalizzate a richiamare in patria molti di loro. “Occorre continuare su questa strada con ancora maggiore coraggio e determinazione, lavorando insieme, e far sì che dal dialogo e dal confronto seguano poi azioni concrete” ha detto la seconda carica dello Sato, facendo riferimento a ” progetti, finanziamenti, norme e strumenti destinati alla ricerca scientifica, alla sperimentazione clinica, all’innovazione tecnologica e un futuro che abbia al centro la difesa della vita, della salute, della sicurezza e della dignità delle persone, della società, della Nazione”.
Ora, al netto di ogni discussione sugli asseriti “chiari segnali di attenzione”, sfuggiti a molti (un peccato che che La Russa non abbia avuto il tempo di dettagliarli), il presidente del Senato ha fornito un altro esempio di quale sia, nella realtà, l’atteggiamento della politica italiana nei confronti di quello che è il primo e principale campo di gioco del nostro futuro: molte e finanche sottoscrìvibili parole per affermare un generico impegno, e però nessuna indicazione su come, quando, con quali strumenti e mezzi quell’impegno lo si intende davvero portare avanti.
Dichiarazioni di intenti, appunto. Del tutto simili – anzi: sovrapponibili – a quelle pronunciate negli anni in mille occasioni da mille altri esponenti politici. Il problema è che le dichiarazioni d’intenti, se non sono seguite da azioni coerenti e conseguenti, sono solo parole: non bastavano prima e sono ancora più inutili oggi. Se ne sono sentire troppe, senza che niente accadesse. Ed è urgente invece, se davvero si vuole che l’Italia conservi un posto nel novero dei Paesi più avanzati, che qualcuno si decida finalmente a far accadere qualcosa.